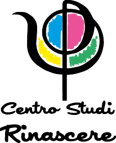BULLISMO

Il bullismo rappresenta quindi una forma di abuso di potere, che si riconosce attraverso tre elementi fondamentali:
-
Intenzionalità: l’aggressione non è casuale, ma è frutto di una scelta consapevole e volontaria.
-
Sistematicità: i comportamenti prevaricatori si verificano con continuità, ripetendosi nel tempo.
-
Asimmetria di potere: tra chi agisce e chi subisce vi è uno squilibrio di forza, che può derivare da fattori fisici (come la corporatura o l’età) o psicologici (come la capacità di relazionarsi o la sicurezza personale). Questa disparità rende difficile per la vittima difendersi, generando in lei un profondo senso di impotenza.
Come si manifesta il bullismo?
Il bullismo può assumere diverse forme e non si limita alla sola violenza fisica — come percosse, calci, pugni, spinte, graffi o strappi ai capelli — né a quella verbale, che comprende insulti, minacce, prese in giro o linguaggio offensivo. Esistono infatti anche modalità più subdole e indirette di aggressione, altrettanto dannose per chi le subisce.
Tra queste rientrano la diffusione di voci infondate o maligne, l’esclusione sistematica dal gruppo dei pari, l’emarginazione, le calunnie e i pettegolezzi mirati a danneggiare la reputazione della vittima.
Nonostante siano meno evidenti rispetto agli atti di violenza fisica, queste forme di prevaricazione risultano profondamente lesive. L’isolamento sociale che ne deriva può essere frainteso dagli adulti o dai coetanei come un’incapacità della vittima di relazionarsi, aggravando così la sofferenza con un’ulteriore forma di ingiustizia: la colpa attribuita a chi subisce.
Chi sono i protagonisti del bullismo?
Nel fenomeno del bullismo, i protagonisti non sono soltanto il bullo e la vittima. Esistono, infatti, diversi ruoli che entrano in gioco e che contribuiscono, in misura diversa, al perpetuarsi delle prepotenze. Possiamo distinguere le seguenti figure:
-
Il bullo leader: è colui che dà origine alle prepotenze, spesso esercitando il proprio potere con atteggiamenti dominanti e aggressivi.
-
I gregari: seguono il bullo e partecipano attivamente agli atti di prevaricazione, assecondandolo e rafforzandone il comportamento.
-
I sostenitori: non agiscono direttamente, ma incoraggiano le violenze con risate, incitamenti o approvazioni implicite, contribuendo a creare un clima di consenso attorno al bullo.
-
La vittima passiva: subisce in silenzio le prepotenze, senza riuscire a reagire o difendersi, spesso a causa della paura o della sensazione di impotenza.
-
La vittima provocatrice: detta anche bullo-vittima, è un soggetto che provoca il bullo con comportamenti irritanti o provocatori, finendo per essere a sua volta bersaglio di aggressioni.
-
Gli spettatori neutrali: assistono alle prepotenze senza prendere posizione. La loro passività, sebbene non attiva, può contribuire a mantenere lo status quo.
-
I difensori della vittima: rappresentano l’unica categoria che si espone per proteggere la vittima, cercando di interrompere le violenze e contrastare l’azione del bullo, anche a costo di esporsi personalmente.
Quali sono le cause del bullismo?
Il bullismo come fenomeno multidimensionale
Il bullismo non è un comportamento isolato, ma un fenomeno complesso e multidimensionale, influenzato da una molteplicità di fattori. Tra questi vi sono i modelli culturali di riferimento, le dinamiche all’interno del gruppo dei pari, l’ambiente scolastico, le caratteristiche individuali dei ragazzi coinvolti, ma anche il contesto familiare e lo stile educativo adottato dai genitori.
Il bullismo come dinamica di gruppo
Il bullismo si sviluppa e si consolida all’interno di un contesto sociale e relazionale che non può essere ignorato, ma al contrario compreso e analizzato. Spesso, ciò che favorisce l’emergere di comportamenti violenti è un clima di omertà, in cui i compagni preferiscono non intervenire, per paura di diventare a loro volta bersagli o per il desiderio di appartenere al gruppo dei “ragazzi popolari”.
Il bullo, infatti, viene talvolta percepito come una figura di riferimento: la sua forza, la sfida all’autorità degli adulti e la popolarità di cui gode tra i coetanei lo rendono un modello attraente. I vantaggi ottenuti attraverso le prevaricazioni possono apparire maggiori rispetto alle eventuali sanzioni. Inoltre, il contesto di gruppo riduce l’inibizione e la responsabilità individuale, facilitando così l’espressione di comportamenti aggressivi.
Il gruppo, infine, offre un forte senso di appartenenza, elemento fondamentale in adolescenza, perché protegge dal rischio dell’isolamento sociale e soddisfa il bisogno di riconoscimento e inclusione.
Il ruolo della famiglia e l’importanza dello stile educativo
La famiglia ha un ruolo centrale nella prevenzione del bullismo, poiché è il primo contesto educativo in cui il bambino apprende a relazionarsi con gli altri. È responsabilità dei genitori trasmettere valori e comportamenti basati sul rispetto di sé e degli altri.
È fondamentale adottare uno stile educativo coerente, affettuoso e orientato al dialogo, in grado di offrire al bambino sicurezza emotiva e punti di riferimento stabili. Fornire poche regole, chiare e comprensibili, coerenti con i bisogni del bambino, significa aiutarlo a sviluppare un’identità solida, una buona capacità di gestione dei conflitti e una tolleranza alla frustrazione.
Solo attraverso un’educazione consapevole e partecipata è possibile formare individui capaci di costruire relazioni sane e rispettose, contrastando attivamente ogni forma di prevaricazione.

Quali sono le conseguenze per la vittima e per il bullo?
I bambini vittime di bullismo possono manifestare un’ampia gamma di segnali, che si riflettono sul piano fisico, psicologico, comportamentale e sociale.
Tra i sintomi fisici più comuni si riscontrano mal di testa, mal di pancia, disturbi gastrointestinali e altri dolori somatici senza cause organiche evidenti.
A livello psicologico, il bullismo può generare ansia, insonnia, incubi ricorrenti, tristezza profonda, fino a sfociare in stati depressivi, insicurezza e bassa autostima.
Queste difficoltà si riflettono anche nel comportamento: la vittima può rifiutarsi di andare a scuola, mostrare un calo del rendimento scolastico o assumere atteggiamenti chiusi e ritirati. Sul piano sociale, tende a isolarsi, evitando il contatto con i coetanei.
Anche chi mette in atto comportamenti di prepotenza può andare incontro a conseguenze negative. I bulli, infatti, manifestano spesso scarso rendimento scolastico, rischio di bocciature o abbandono degli studi, e difficoltà nelle relazioni interpersonali, soprattutto per la scarsa capacità di rispettare le regole e le autorità.
Nel lungo termine, i soggetti con comportamenti aggressivi hanno maggiori probabilità di sviluppare condotte devianti e antisociali, come atti di vandalismo, furti, consumo di sostanze e, in alcuni casi, veri e propri reati.
Quando rivolgersi ad uno psicoterapeuta?
È fondamentale prestare attenzione ad alcuni segnali che indicano un malessere profondo nel bambino. In particolare, è importante intervenire quando il minore manifesta sintomi significativi come depressione, ansia persistente, incubi ricorrenti, comportamenti autodistruttivi e una marcata bassa autostima.
Se il suo vissuto emotivo interferisce con il normale equilibrio psicologico, influenzando negativamente le relazioni sociali, il rendimento scolastico e il benessere generale, non si tratta più di un disagio passeggero, ma di una condizione che richiede attenzione e supporto.
Un altro campanello d’allarme è rappresentato dalla ricorrenza degli episodi di bullismo: se vostro figlio è stato vittima di prepotenze in contesti differenti e da parte di persone diverse, questo indica una fragilità relazionale che va compresa e affrontata con il sostegno di figure competenti.
Quando un bambino è vittima di bullismo, non soffre solo nel momento dell’aggressione: le conseguenze possono segnare profondamente la sua autostima, il suo modo di relazionarsi con gli altri e la percezione di sé. È qui che entra in gioco la figura dello psicoterapeuta.
Lo psicoterapeuta aiuta la vittima a ritrovare fiducia in sé stessa, a gestire ansia, paura e vergogna, e a sviluppare competenze sociali per difendersi in modo sano e non violento. Ma non lavora solo con chi subisce. Anche il bullo può e deve essere seguito, per capire le cause del suo comportamento e imparare a relazionarsi con gli altri in modo rispettoso e costruttivo.
Inoltre, coinvolgere la famiglia è fondamentale: i genitori devono sentirsi sostenuti e guidati in uno stile educativo basato sul dialogo, sull’ascolto e sul rispetto reciproco.
Infine, lo psicoterapeuta può collaborare con la scuola per costruire un clima positivo e prevenire l’omertà che spesso circonda questi episodi. Perché il bullismo si combatte insieme, partendo dall’ascolto e dalla cura delle relazioni.
CONSULENZA LEGALE
Oltre al supporto psicologico, offriamo anche un servizio di consulenza legale specializzata per tutelare i diritti del minore e della famiglia.
In collaborazione con professionisti esperti in diritto scolastico, accompagniamo i genitori nella verifica delle responsabilità della scuola, dell’attuazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) o del Piano Didattico Personalizzato (PDP), e del rispetto dei protocolli previsti in caso di episodi di bullismo.
La nostra priorità è garantire un intervento tempestivo e completo, che integri l’aspetto psicologico con quello legale, per una presa in carico efficace e orientata alla tutela del benessere del minore.
Scrivici per maggiori informazioni
CONTATTI
Via Italo Svevo 12, Giugliano in Campania
80014
enza.cipolletta@yahoo.it